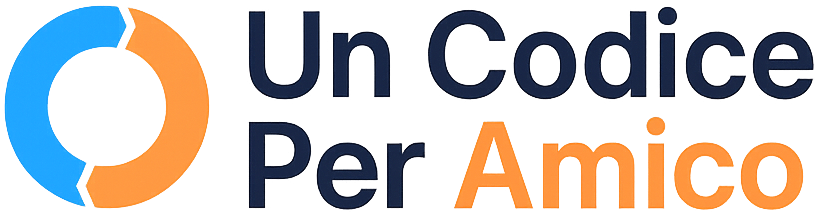Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza. Leggi di più

Malamente orecchiata, ricomposta dal pensiero occidentale, per vacuità riempita da immaginari esotismi, l’alchimia taoista diventa spesso il crogiolo di un “sentito dire” volgarizzato e piamente digerito attraverso i centoni collazionanti della cultura prêt-à-porter. Vero è che le ricerche moderne sul taoismo possono datarsi, come ricorda Schipper, soltanto dal 1926, quando l’unico esemplare del Canone Taoista completo, conservato a Pechino nel Tempio della Nuvola Bianca, venne riprodotto fotolitograficamente e fatto circolare, ma anche vero è che dai tempi di Matteo Ricci l’Occidente prestò più agevole ascolto ai modelli di cultura confuciani proposti, nella loro dimensione normativa, come più assimilabili al cristianesimo e lontani da “bizzarre” prassi operative. Per altro, il lettore italiano ha avuto a disposizione, in questi ultimi anni, i testi tradotti di autori quali Granet, Maspero, Needham che superando la stretta categoria dei sinologi, hanno permesso di poter affrontare con maggior successo d’intendimento le poche usuali, ma affascinanti espressioni del pensiero cinese.Questa una prima ragione per cui non estranea apparirà al lettore di testi alchemici occidentali il Pao-P’u Tzu Nei P’Ien opera nel IV secolo di Ko Hung, curata e tradotta dal testo originale da Fabrizio Pregadio con dotta pazienza e amore di rispondenza analogica; una seconda ragione garberà al lettore quando scoprirà, via via che proceda nella lettura, la similarità morfologica, non solo di prassi