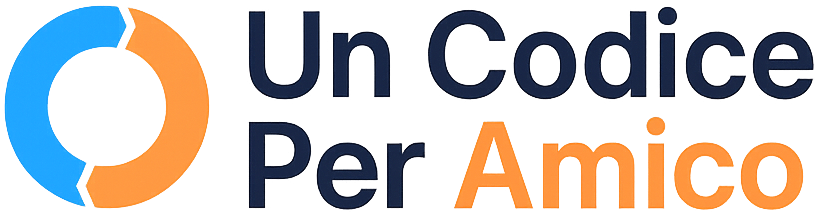Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza. Leggi di più

«Secondo Croce e Salvatore la stagione decisionista sarebbe circoscritta a un periodo molto breve, e cioè ai primi anni Venti, perché già a partire dal 11927-28 lo sguardo di Schmitt sembra spostarsi altrove. L'individuazione del cuore della sovranità nella capacità di decidere sullo "stato di eccezione"" sarebbe così soprattutto il riflesso della polemica contro la Costituzione di Weimar, oltre che contro Hans Kelsen e Max Weber, i quali — in modo molto diverso — avevano ritenuto che la legittimità potesse risolversi nella legalità» - Damiano Palano, AvvenirernCarl Schmitt è forse la figura intellettuale più controversa del Novecento, il cui spettro torna immancabilmente a palesarsi ogniqualvolta gli ordinamenti costituzionali vengano messi sotto pressione e pongano limiti alle libertà fondamentali da essi stessi sancite. Campi di prigionia, populismi d'ogni colore, decretazione d'urgenza, misure restrittive a fronte di un'emergenza pandemica e molti altri esempi recenti di provvedimenti che limitano i diritti di libertà: ad ogni minimo cedimento degli Stati democratici, si invoca Schmitt come nume tutelare o ispiratore dannato. Ma questo uso del pensiero schmittiano è davvero fedele alla teoria del giurista tedesco? L'indecisionista offre una risposta netta, ed è un no. Al di là delle letture sclerotizzate che schiacciano Schmitt sulla triade eccezione, decisione e opposizione amico-nemico, il libro mostra come egli abbia sostenuto il ""decisionismo eccezionalista"" per un